Milano (Italy) Martedì 19 febbraio 2002 Niente rogo per il libro maledetto GIORDANO BRUNO GUERRI
Il problema, con Irving, è questo. Si tratta di un innovatore o del fazioso rappresentante di una destra estrema? Riassumiamo la sua vicenda, che da anni si aggira sul giornali e nel dibattiti storiografici di tutto il mondo.Inglese di 62 anni, figlio di un ufficiale della Royal Navy che abbandonò in povertà la famiglia, studente mal arrivato alla laurea, emigrante e operaio in Germania (da qui la sua ottima conoscenza del tedesco), nel 1963, poco più che ventenne, pubblicò Apocalisse a Dresda, un saggio che accusava la Gran Bretagna di olocausto per il bombardamento che nel febbraio del 1945 fece 200 mila inutili vittime, per lo più profughi, e distrusse un patrimonio artistico immenso. Il libro, molto documentato e ancor meglio scritto, ebbe un successo mondiale.
Irving, oltretutto, non nasconde il suo razzismo: cantava filastrocche antisemite alla sua bambina e dice: «Se fossi un ebreo, non mi chiederei tanto chi abbia premuto II grilletto, ma perché». Quando la studiosa americana Deborah Lipstadt lo definì, in un libro, «bugiardo» e «negatore dell'Olocausto» fu lui -- nel 1999 -- a volere un processo clamoroso denunciandola per diffamazione.Alla fine di marzo del 2000 il giudice inglese incaricato del caso, Charles Gray, decise che Irving è un «razzista antisemita», un «negatore dell'Olocausto» e un «filonazista», condannandolo a un risarcimento di sei miliardi. Dal punto di vista storiografico, l'accusa più grave è quella di avere negato l'esistenza di qualcosa che invece esistito. Persino fra i tradizionalisti furono pochi gli storici che se la sentirono di andare a testimoniare contro Irving. Poco dopo la sentenza Eric I. Hobsbawn, osannato storico inglese di formazione marxista, sorprendendo tutti in una lectio magistralis all'Università di Torino, se la prese più con gli storici tradizionali che con Irving, accusandoli di ribattere in modo ozioso e rituale alle teorie e ai documenti del suo compatriota.Benché convinto dell'Olocausto, Hobsbawn sostenne che gli studiosi come Irving devono essere prima di tutto letti, poi scientificamente controllati, infine altrimenti contestati, perché ai libri di storia si risponde con i libri di storia. Nel 1998, due anni prima della sentenza, scrissi sui Giornale un articolo in polemica con Piero Buscaroli. Sostenevo -- con molte argomentazioni -- che, ordine firmato o no, la portata dello sterminio fu tale da rendere impensabile che la «soluzione finale» non fosse voluta da Hitler o tentata a sua insaputa. E che tutto il pensiero nazista conduceva a quello.Il fatto stesso che ora senta il bisogno di mettere le mani avanti, e in qualche modo di giustificarmi, per le idee che ho espresso e che esprimerò in questo nuovo articolo, è rivelatore del clima culturale allineato e inquisitoriale regnante anche in Italia e per iI quale l'opera di Irving deve essere rigettata in blocco, senza neanche valutarla. E il caso di parlane, invece, visto che finalmente è uscito anche da noi Hitlers War. La guerra di Hitler nasce dalla fusione di Hitlers War (1977) e The War Path (1979), che lo stesso Irving unificò in un solo volume e che aggiorna di continuo. nel 1997 la Mondadori, editore italiano di altri suoi saggi, comprò i diritti del libro. Poi rinunciò a pubblicano perdendo l'anticipo versato. Poteva farlo; infatti lo stesso Irving lamenta soltanto che la decisione gli venne comunicata due anni dopo, ritardando così la ricerca di un nuovo editore. sintomatico che lo studioso inglese sia dovuto passare dal marchio del più grande editore italIano a quello di una casa editrice piccolissima e di una Destra che con il Polo ha poco o nulla a che fare, il Settimo Sigillo di Roma. Le dobbiamo essere grati per aver messo a disposizione degli italiani un libro importante, se non altro per le discussioni che ha sollevato. Invece non c'è molto da rallegrarsi, per la cultura del Paese, che tutte le altre case editrici abbiano rifiutato o neanche preso in considerazione un saggio che -- quali che siano le opinioni dell'autore -- contiene una quantità impressionante di documenti inediti e sicuramente autentici. Né che La guerra di Hitler (pagg. 1.000, euro 60, tel. 06/39722155), pubblicato alla fine del 2001, sia stato accolto dalla stampa con un silenzio assoluto quanto prudente. Ciò detto, sarebbe stato meglio se Settimo Sigillo avesse pubblicato anche le note invece di spiegare, nella Presentazione, che sono quasi inutili al lettore non specializzato e che le si può trovare in un sito Internet: anche se di poca utilità pratica, danno la percezione esatta di un immenso e minuzioso lavoro di ricerca che illustra il volume molto meglio delle tante foto di Hitler, gerarchi e militari in versione simpatica e sorridente. Veniamo ai contenuti. La guerra di Hitler intende dichiaratamente mostrare come la Seconda Guerra Mondiale fu vista da Berlino. Irving tiene conto sia dell'elemento ideologico di partenza, che determinava le scelte del Führer, sia di quanto influivano in quelle scelte i risultati delle campagne di guerra. E un taglio storiografico utile, di cui fa uso anche la scuola revisionista tedesca. Un secondo elemento che differenzia il Volume dall'usuale storiografia è che non si tratta di una storia scritta dai vincitori. Non ci sono quindi pregiudizi e giudizi moralistici, come la superiorità del sistema democratico rispetto a quello nazista o viceversa. Di conseguenza sia gli storici sia i lettori comuni -- completamente immersi nelle convinzioni dei vincitori -- hanno l'immediata e inevitabile sensazione che il saggio contenga fondamentali errori di base, ma non è vero. Facciamo un esempio dei nostri giorni: il conflitto fra integralismo islamico e occidente democratico è inconciliabile, perché entrambi i contendenti sono sinceramente convinti di essere nel giusto. Io, storico nato e vissuto nella cultura occidentale, sono convinto che la difesa dei valori della libertà, della democrazia, della parità fra donna e uomo sia più importante della difesa dei precetti del Corano; dunque ho approvato i bombardamenti sull'Afghanistan senza curarmi molto siamo in guerra -- di valutare e giustificare storicamente l'ideologia del nemico. Se invece dovessi scrivere un saggio sulle ribellioni degli arabi durante il periodo coloniale, sarebbe mio dovere riuscire anche a pensare come un musulmano.Irving fa proprio questo, e gli riesce particolarmente bene per il suo evidente filonazismo.Forse è ancora meno obiettivo dei suoi contestatori, ma svolge un lavoro necessario che -- depurato degli eccessi -- dovrebbe essere utile soprattutto agli storici di parte avversa. Prendiamo a esempio un aspetto molto «urtante» della Guerra di Hitler. Irving, cadendo in palesi eccessi di simpatia, si sforza di dimostrare -- e lo ammette da subito -- che la figura umana del Führer era lontana da quella de! pazzo, depravato e criminale tramandata dai vincitori. E una delle ragioni dell'ostracismo cui sono stati sottoposti Irving e la sua opera.Pagina dopo pagina, dal volume trapela la volontà di mettere in discussione, sempre attraverso documenti inediti, l'immagine di Hitler demone e incarnazione del male assoluto. Non si tratta più soltanto del risibile (e assai irriso) luogo comune nostalgicopopolare per cui Hitler non era poi così cattivo, visto che amava i cani ed era vegetariano.Irving documenta un Führer attento alle esigenze dei suoi collaboratori in una cameraderie sincera; che si preoccupa e si attiva per un aviatore qualsiasi, in pericolo per il maltempo; che censura i film hollywoodiani ma ama Shirley Temple. Le responsabilità del Führer non diminuiscono per questo, ma qualsiasi studioso (lei nazismo sa che in Hitler -- anche nella quotidiana gestione del potere -- c'erano singolari tratti di dolcezza, delicatezze d'animo che potevano coesistere con la durezza di un uomo capace di dare ogni giorno ordini che avrebbero portato alla morte decine di migliaia di individui, tedeschi e nemici. Ma la politica e l'ideologia dominanti non vogliono sia infranto il tabù di un Hitler esclusivamente malvagio e spietato. È un atteggiamento che non fa bene alla storiografia, gli storici lo sanno, anche se lasciano prevalere la prudenza di chi tiene alla cattedra, al rassicurante tran-tran della carriera universitaria e ai vantaggi che ne derivano. Il saggio di Irving riporta anche, con minore vigore bibliografico, i principali dati acquisiti dalla storiografia sulla guerra e sul perché della condotta tedesca: la volontà di creare uno «spazio vitale» a Est che permettesse la grandezza germanica a danno dell'Unione Sovietica; il binomio ideologico di marca prussiana, antico di trecent'anni, che fonda l'identità nazionale sulla comunità di sangue e terra; l'incompatibilità antitetica con la «non razza» ebraica che secondo i nazisti non poteva avere un'identità di popolo in quanto legata dalla religione e non da quel binomio; la visione biologistico-darwiniana dello sviluppo delle società umane; la certezza di trovare un accordo con la Gran Bretagna, durante gli anni della guerra, per l'impossibilità di credere a un'unione sincera e durevole fra modello di sviluppo capitalistico occidentale e modello bolscevico.
E torniamo all'Olocausto. Che ci fu. Ma che è impossibile definire scientificamente, in assenza di documentazione non a caso in parte distrutta, e forse in parte contraffatta, dai nazisti. Ho già detto che, secondo Irving, Hitler si sarebbe accontentato della deportazione degli ebrei in Madagascar e che si decise allo sterminio nel 1943, quando l'eccessivo numero di prigionieri di tutti gli eserciti, unito ai deportati ebrei e all'andamento critico della guerra, non consentiva più di nutrire -- per quanto poco -- tante bocche non tedesche. Irving giustifica la decisione con il problema di garantire almeno la sopravvivenza della Germania. Con questa teoria, per paradosso, smentisce prima di tutti se stesso, dopo aver cosi ben spiegato la logica ideologicoreligiosa di Hitler: il nazismo e la sua dottrina consentivano a un grande popolo dal grande passato di ergersi a giudice, con diritto di vita e di morte sugli altri popoli, pur di realizzare i suoi alti destini. Tutto ciò appare immorale, ripugnante, ingiustificabile e incomprensibile, ma almeno gli storici dovrebbero poter entrare nella concretezza, vastità e profondità di un credo laico, antindividualista e razzista terribilmente vivido nello spirito del XX secolo. Irving considera questo aspetto, ma purtroppo il suo filonazismo e i suoi eccessi finiscono per renderne il lavoro controproducente e per colpire il sano revisionismo storiografico -- che dovrebbe significare assenza totale di giudizi di valore e di giudizi storici conclusi -- alimentando polemiche che vanno oltre la storia. Irving sottopone così a facili attacchi uno studio che -- come espressione di dissenso al dogma delle chiese politiche e storiografiche -- invita anche la coscienza civile del nostro Paese a fare i conti con la storia. Per esempio cominciando a prepararsi all'idea che De Felice, per quanto meritevole, non ha scoperto, capito e scritto tutto del fascismo; che quello degli italiani non fu solo consenso, ma per lo più entusiasmo; che non c'è da vergognarsene, anche perché il trionfo del fascismo ha radici antiche e molto lontane da noi; che un bilancio davvero corretto dei meriti e dei demeriti del regime non è stato ancora fatto; che Mussolini -- la cui reale e immensa fascinazione su uomini e masse deve essere ancora seriamente studiata -- ebbe una straordinaria visione dello Stato, infinitamente superiore a quella dei suoi connazionali; che gli italiani si batterono poco o nulla perla propria libertà, perché della loro libertà importava loro poco o nulla; che non vale dire «se Mussolini non avesse fatto la guerra», perché nel 1940 gli italiani la volevano con la stessa furbizia e per gli stessi motivi imperialistici del duce; che la combattemmo spesso male e molto spesso con una durezza e una crudeltà che è piacevole fingere di ignorare, ma che sarebbe meglio riconoscere. Forse qualcuno mi darà del fascista, con articoli
fragili quanto la sua autonomia di pensiero, la sua
onestà intellettuale o le sue conoscenze in materia.
Sappia sin da ora che non riceverà querele, non
perché io sia fascista, ma perché lui è
un deficiente: «Persona totalmente o parzialmente
minorata nella sua attività intellettuale»
(Treccani).
|
 «A
gli storici è concesso un potere che persino agli dei
è negato: cambiare ciò che, è
già accaduto». Così scrive David Irving
intendendo che lo storico può cambiare le
interpretazioni del passato fino ad allora credute vere. Ha
ragione, ma con qualche distinguo importante. Lo storico
è il tecnico specializzato al quale la società
affida il compito di illuminare il passato, a patto che
rispetti il «comune sentire» della società
e del tempo in cui vive. Insomma, ha il potere di decidere
la storia ufficiale solo chi rappresenta il pensiero medio
ufficiale. Se quel pensiero è diviso -- mettiamo --
in destra e sinistra, ci sarà una storiografia media
e ufficiale di destra e una media e ufficiale di sinistra.In
mezzo, qualcuno cercherà di conciliare le due
interpretazioni, dando la media dei medi, ma con risultato
incerto, perché la verità davvero non sta
sempre nel mezzo. Poi, a un certo punto, arrivano i
portatori di un pensiero storiografico nuovo, originale e
ridocumentato: sono i cosiddetti «revisionisti»,
storici innovatori che chiudono un'epoca e ne aprono
un'altra.Come Renzo De Felice, per citare il più noto
da noi. Anche loro, però, sono soltanto avanguardie
di quello che è destinato a diventare il pensiero
medio, a breve, perché se la società e i tempi
non fossero maturi per il cambiamento, le loro teorie, non
avrebbero avuto abbastanza capacità di
penetrazione.
«A
gli storici è concesso un potere che persino agli dei
è negato: cambiare ciò che, è
già accaduto». Così scrive David Irving
intendendo che lo storico può cambiare le
interpretazioni del passato fino ad allora credute vere. Ha
ragione, ma con qualche distinguo importante. Lo storico
è il tecnico specializzato al quale la società
affida il compito di illuminare il passato, a patto che
rispetti il «comune sentire» della società
e del tempo in cui vive. Insomma, ha il potere di decidere
la storia ufficiale solo chi rappresenta il pensiero medio
ufficiale. Se quel pensiero è diviso -- mettiamo --
in destra e sinistra, ci sarà una storiografia media
e ufficiale di destra e una media e ufficiale di sinistra.In
mezzo, qualcuno cercherà di conciliare le due
interpretazioni, dando la media dei medi, ma con risultato
incerto, perché la verità davvero non sta
sempre nel mezzo. Poi, a un certo punto, arrivano i
portatori di un pensiero storiografico nuovo, originale e
ridocumentato: sono i cosiddetti «revisionisti»,
storici innovatori che chiudono un'epoca e ne aprono
un'altra.Come Renzo De Felice, per citare il più noto
da noi. Anche loro, però, sono soltanto avanguardie
di quello che è destinato a diventare il pensiero
medio, a breve, perché se la società e i tempi
non fossero maturi per il cambiamento, le loro teorie, non
avrebbero avuto abbastanza capacità di
penetrazione.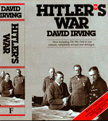 Quel
volume gli aprì molti cassetti degli eredi di
militari, funzionari, piccoli e grandi gerarchi nazisti, e
nel 1977 Irving poté pubblicare
Quel
volume gli aprì molti cassetti degli eredi di
militari, funzionari, piccoli e grandi gerarchi nazisti, e
nel 1977 Irving poté pubblicare 